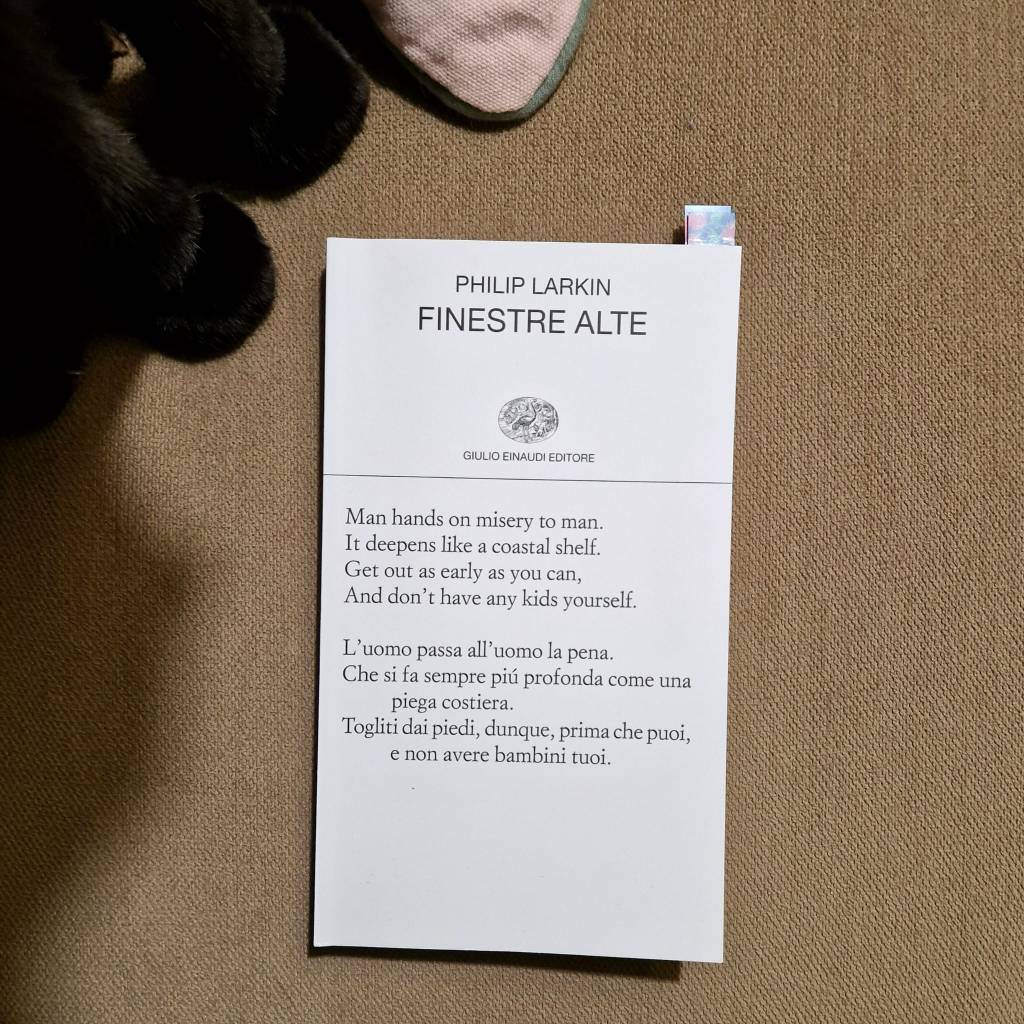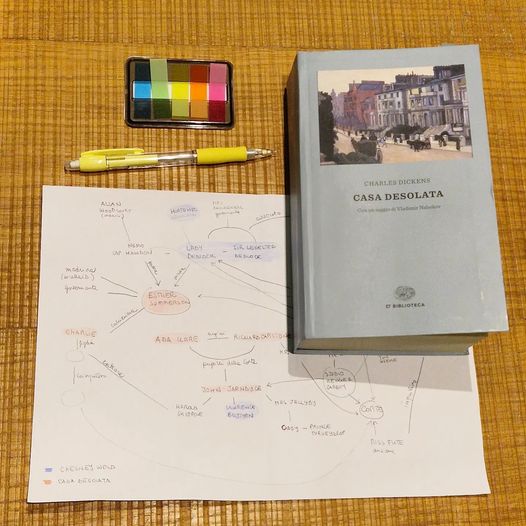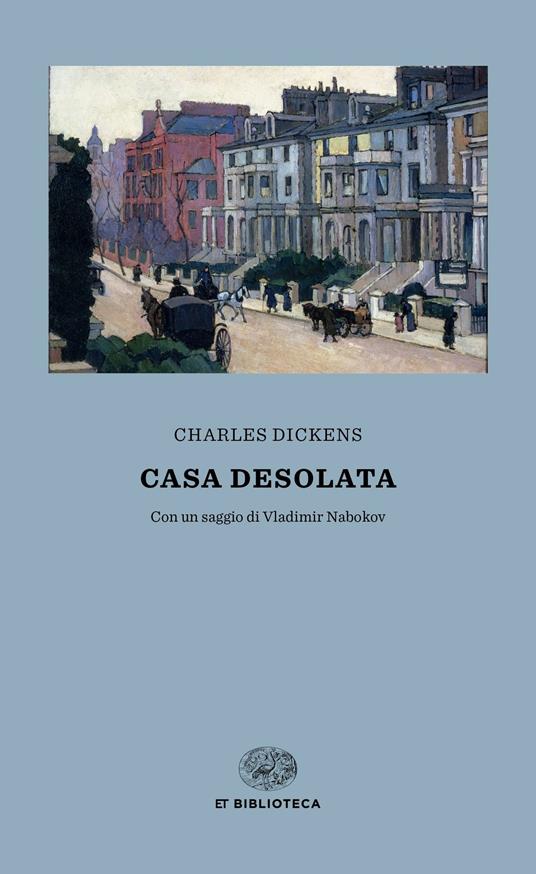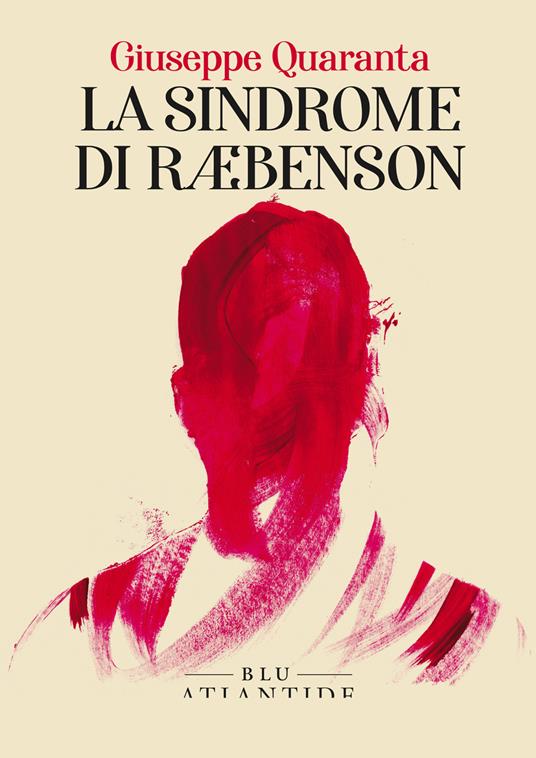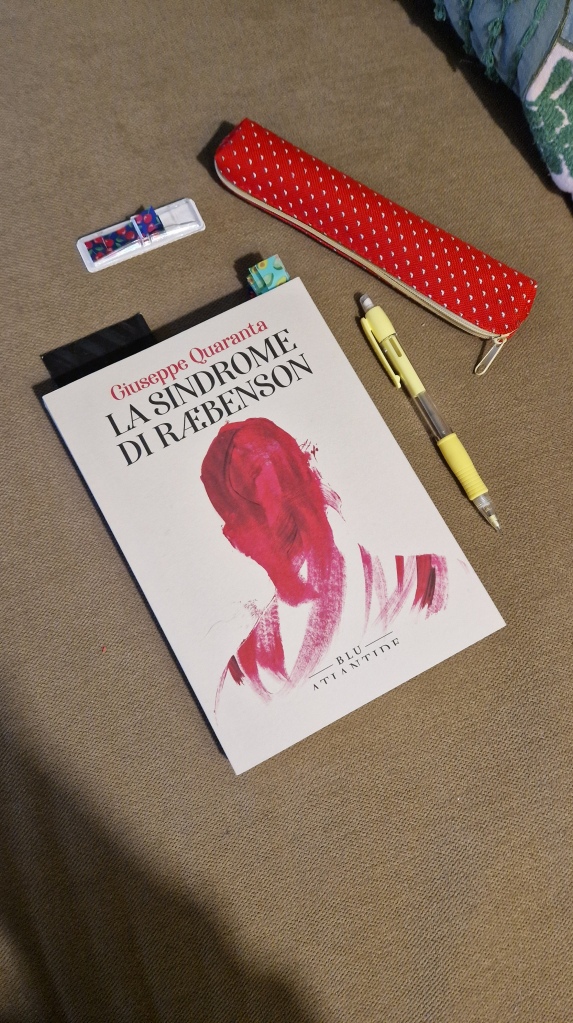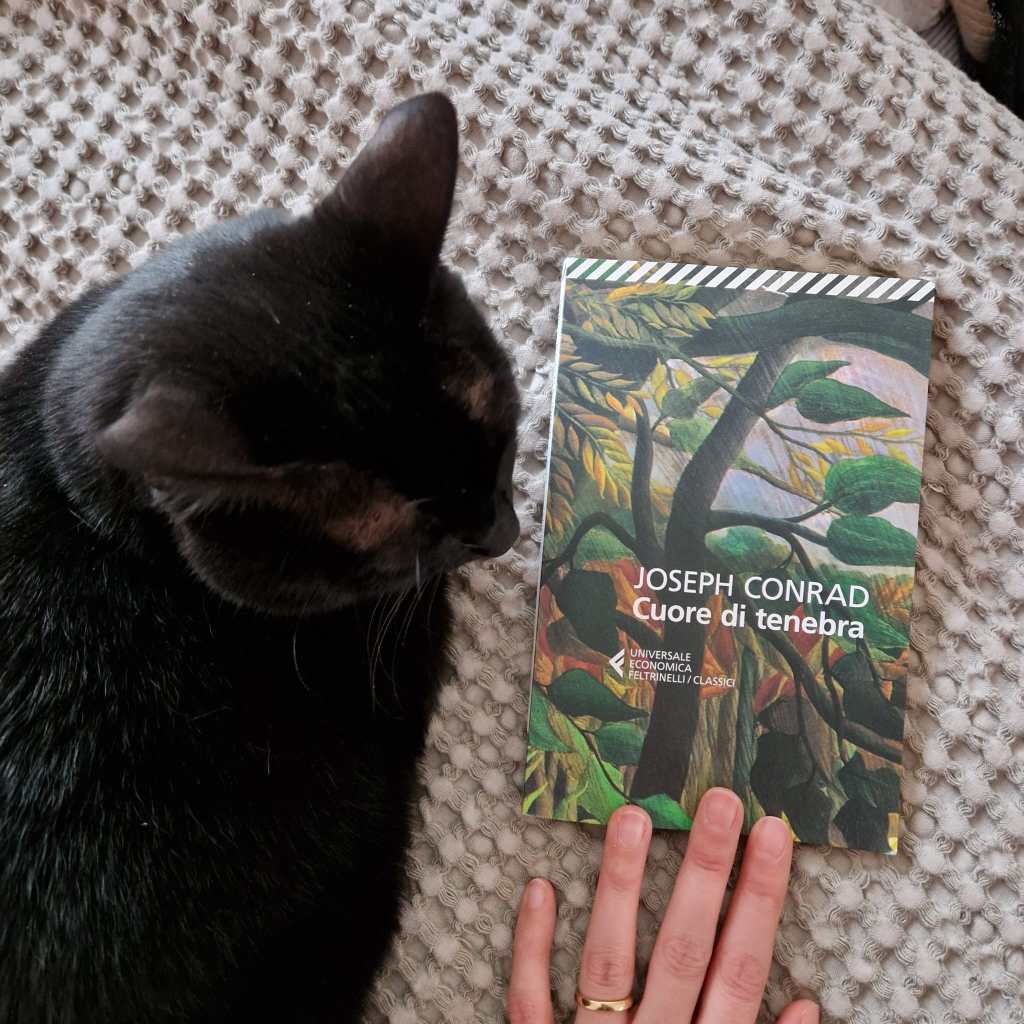
Ritmico come i tamburi della foresta, il richiamo dell’ignoto ammalia i personaggi di questo romanzo breve di Joseph Conrad. Scritto nel 1899, quando l’autore aveva abbandonato ormai definitivamente la vita da marinaio per dedicarsi alla scrittura, Cuore di tenebra (Heart of darkness) sembra rifarsi al viaggio di Conrad in Congo e ai vari tipi di avventurieri che aveva incontrato durante le sue navigazioni.
Mentre Londra balugina in lontananza avvolta da una oscurità tetra, un gruppo di amici attende su un’imbarcazione che la marea del Tamigi inverta il suo flusso per poter attraversarne la foce e raggiungere il mare. Cala una notte buia e Marlow, uno dei cinque tra i quali sta il narratore, si lascia andare ai ricordi e inizia il racconto di una sua avventura nel cuore profondo dell’Africa, quando aveva abbandonato i mari per dedicarsi all’esplorazione del grande fiume che simile a un alligatore lo chiamava dalle carte geografiche. Marlow tenta di tutto per poter raggiungere quei luoghi ma solo l’influenza di una zia che vive nel Continente potrà concedergli di prendere servizio presso la Compagnia che gestisce i commerci in quell’area e farsi affidare la guida di un battello.
Fin dalle prime righe si avverte un senso di oppressione, il peso di un fato oscuro, l’irresistibile vocazione dell’uomo verso l’ignoto. Novello Ulisse, Marlow è spinto da una cieca sete di conoscenza e nemmeno l’inquietante visione delle due parche che filano nera lana all’ingresso della Compagnia, una giovane l’altra anziana, quest’ultima con un gatto in grembo e lo sguardo di chi sa che non vedrà tornare nessuno di quelli che sono partiti, lo trattiene da affrontare disagi di ogni tipo per prendere il comando del suo battello.
In un crescendo di tensione, in un continuo evocare la tenebra e il mistero inconoscibile della foresta, Cuore di tenebra è il racconto di un’ossessione alla quale si può sacrificare tutto, anche la propria anima.
In fondo al fiume, nell’ultima stazione, sta Kurtz, il migliore degli agenti della Compagnia, ammirato e odiato allo stesso tempo per la sua eloquenza e la sua bravura nel procurare avorio. Simile a un mito o a una leggenda, il suo nome si ripete sempre più spesso e assume per Marlow la consistenza di una voce, un canto di sirena da cui si sente irrimediabilmente attratto e allo stesso tempo respinto.
Il racconto è incalzante, costellato da diversi episodi che, attraverso gli occhi di Marlow, ci presentano la cupidigia e la grettezza dell’uomo bianco, venuto da predone a strappare alla foresta e agli indigeni i loro beni e i loro segreti. Schiavi, nemici, ribelli: Marlow è disgustato dal trattamento riservato a quegli uomini, spesso sofferenti, indigenti, sottomessi all’invasore. Di contro ci sono le tribù ancora libere, che oppongono una resistenza silenziosa e hanno trovato in Kurtz un idolo da cui sono terrorizzati e ammaliati allo stesso tempo.
Il personaggio di Kurtz domina il romanzo: prima solo presenza, poi corpo per quanto consumato, ridotto a una voce ancora potente, ancora in grado di dare ordini, di gridare l’orrore. L’attesa spasmodica di Marlow di poterlo finalmente ascoltare, quell’uomo la cui eloquenza ha conquistato europei e indigeni, si scontra con la realtà di uno spirito che ha visto se stesso e ne ha provato orrore, per la propria cupidigia, per la propria bramosia di potere, per la violenza alle quali non sa opporsi ma sempre si abbandona.
Due figure di donna si stagliano antitetiche tra loro alla fine del racconto, in parallelismo con le due donne vestite di nero. Una è una fiera indigena, figura oscura, voce della foresta, che sembra chiamare a sé Kurtz, portato sul battello per riportarlo alla civiltà. Un richiamo a cui lui cede, per poi essere di nuovo catturato da Marlow. L’altra è la fidanzata che a lungo lo ha aspettato in patria e che ora indossa le gramaglie di una vedovanza affranta. Quanto l’altra era scura e irrazionale, tanto questa è luminosa, i capelli biondi accesi dagli ultimi raggi del sole calante, piena di fede nell’uomo che ancora ama e che ritiene il migliore tra tutti. Entrambe le figure tendono le braccia a implorare qualcosa da quest’uomo senza cuore. Il suo infatti glielo ha strappato la foresta, con i suoi silenzi di tenebra e i misteri che la mente umana non potrà mai sondare.
Sbarcare in una palude, marciare nei boschi e sentire in qualche avamposto dell’interno la natura selvaggia, assolutamente selvaggia, chiudersi intorno a lui – tutta quella vita misteriosa che si agita nella foresta, nelle giungle, nel cuore dei primitivi. Non esiste iniziazione a questi misteri. È costretto a vivere nel cuore dell’incomprensibile, che è anche detestabile. E ha un fascino, che comincia ad agire su di lui. Il fascino dell’orrore, capite – e immaginate i rimpianti sempre più intensi, il desiderio di fuggire, il disgusto impotente, la resa, l’odio. (pagina 10)L’ombra del Kurtz di un tempo frequentava il capezzale del vuoto ciarlatano, destinato a sepoltura imminente nel terriccio della terra primordiale. Ma l’amore demoniaco e l’odio irrazionale dei misteri che aveva penetrato si stavano battendo per impadronirsi di quell’anima sazia di emozioni primitive, avida di fama menzognera, di distinzione fasulla, di tutte le apparenze del successo e del potere. (pagina 99)